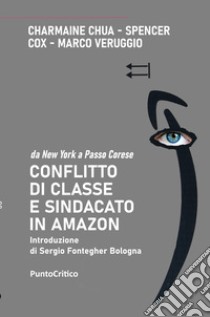HyperHouse
NeXT Hyper ObscureArchivio per Cerebralità
Alien PROMETHEUS & COVENANT | IL FILO A PIOMBO DELLE SCIENZE
 Due post molto articolati – com’è costume di Marco Moretti – sul blog Perpendiculum (qui e qui) per raccontare, analizzare, speculare sui due film sequel – o prequel – della saga di Alien, del regista Ridley Scott. Invito a leggere attentamente cosa propone Marco, una rilettura della proposta di Scott che subodoravo da tempo e che va in netta controtendenza col gusto comune del pubblico; insiti nella critica proposta alcuni concetti estremi, ma non per questo meno accattivanti, meno interessanti. Un piccolo estratto:
Due post molto articolati – com’è costume di Marco Moretti – sul blog Perpendiculum (qui e qui) per raccontare, analizzare, speculare sui due film sequel – o prequel – della saga di Alien, del regista Ridley Scott. Invito a leggere attentamente cosa propone Marco, una rilettura della proposta di Scott che subodoravo da tempo e che va in netta controtendenza col gusto comune del pubblico; insiti nella critica proposta alcuni concetti estremi, ma non per questo meno accattivanti, meno interessanti. Un piccolo estratto:
Ridley Scott ha intitolato il film Prometheus perché riteneva che il nome si adattasse perfettamente alla trama. Questo ebbe a dire: “È la storia della Creazione, degli Dei e dell’uomo che si oppose a loro”. Nella mitologia greca, il Titano Prometeo era un servitore immortale degli Dei, che rubò e diede al genere umano il dono del fuoco divino. Questo beneficio incommensurabile cambiò l’umanità per sempre – nel bene e nel male. In altre parole, Prometeo ha reso l’Uomo pericoloso per gli Dei.
Per la prima volta da Alien³ viene mostrata la realtà vista da un alieno. Tuttavia, in Alien: Covenant vediamo l’effettivo spettro visivo della creatura, il che conferma che gli xenomorfi possono effettivamente vedere nonostante una credenza diffusa li voglia sprovvisti di occhi. Nel corso degli anni i fan hanno delirato producendo un gran numero di ipotesi: a loro detta le teste a cupola allungate degli alieni sarebbero determinanti nel convertire la luce, i segnali di calore, l’odore, il suono e le vibrazioni in dati visivi. In realtà questi parassitoidi hanno gli occhi, solo che sono nascosti da una placcao di polimero trasparente dall’interno, che fa parte del cranio. Nei neomorfi gli occhi occupano una piccola fossetta e i nervi ottici che li collegano al cervello non sono visibili nella sezione che David ha disegnato, realizzato ed esposto nel suo laboratorio.
Qualcosa che ti rende…
Qualcosa striscia indifferente sotto il livello della realtà, rendendoti libero di essere interiore e consapevole o di esserne schiavo.
Esce “Kotodama”, raccolta di haiku giapponesi di Maria Laura Valente e fotografie di Stefano Bertoli | KippleBlog
[Letto su KippleBlog]
 Da oggi è disponibile su www.kipple.it la plaquette Kotodama, silloge di haiuku giapponesi in lingua italiana di Maria Laura Valente e fotografie originali di Stefano Bertoli, con traduzioni in anglo-americano della stessa Maria Laura Valente coadiuvata da John Martone; le traduzioni in lingua giapponese sono di Ban’ya Natsuishi e la prefazione è di Diego Martina, la postfazione è di Sonia Caporossi.
Da oggi è disponibile su www.kipple.it la plaquette Kotodama, silloge di haiuku giapponesi in lingua italiana di Maria Laura Valente e fotografie originali di Stefano Bertoli, con traduzioni in anglo-americano della stessa Maria Laura Valente coadiuvata da John Martone; le traduzioni in lingua giapponese sono di Ban’ya Natsuishi e la prefazione è di Diego Martina, la postfazione è di Sonia Caporossi.
LA QUARTA
La «parola-spirito» kotodama 言霊è vocabolo totemico, nonché rivelatore, dello spirito (ani)mistico e poetico del Giappone più ancestrale, il cui concetto fondativo, come rilevato da Pierantonio Zanotti, pertiene all’ambito antropologico prima ancora che a quello letterario, giacché «indica il potere performativo […] della parola […] abitata da forze in grado di agire sul mondo materiale».
A ciò sembra essere sotteso un ineluttabile stato di promiscuità tra umano e divino (quest’ultimo da intendersi come spirituale lato sensu), un meticciato ontologico primigenio, la cui intrinseca armonia metatemporale trova la propria condicio sine qua non tanto nel riconoscimento del potenziale liberatorio di una tale sincresi primeva quanto nel makoto no kokoro («cuore sincero»).
GLI AUTORI
Maria Laura Valente (Campobasso, 1976), classicista, poetessa, haijin e critico letterario, vive a Cesena, dove lavora come docente liceale di Letteratura latina e italiana. Si occupa di critica letteraria collaborando con i lit-blog “Poesia del Nostro Tempo”, “ParolaPoesia”, “Versante Ripido” e “Cinquesettecinque”, nonché con il periodico cartaceo “Graphie – Rivista Trimestrale di Arte e Letteratura”. È membro di giuria nei premi letterari “Bologna in Lettere” e “Versante Ripido”, fa parte dello staff organizzativo del festival multidisciplinare “Bologna In Lettere”. Come poetessa, ha pubblicato le raccolte Giochi d’Aria (Rupe Mutevole, 2010), Lustralia – Abluzioni liriche (LunaNera, 2016) e La memoria del dolore (Progetto Cultura, 2022). Nell’ambito della poesia haiku in lingua italiana, oltre a comparire su riviste e antologie di settore, ha pubblicato le sillogi La carezza del vento (LunaNera, 2018) e Hatsuyume (La Ruota, 2019), con cui ha conseguito il Premio Speciale della Critica nell’VIII edizione del Premio Nazionale di Poesia L’Arte in Versi nel 2019). Annoverata per tre anni consecutivi tra i 100 haikuists più creativi d’Europa (Haiku Euro Top, 2016-2018), suoi componimenti sono stati esposti al pubblico nelle città di Washington (Golden Triangle Haiku Contest, Marzo 2018) e di Dublino (Nickie Hayden’s Haiku Wheel / Sanctuary Exhibition @Olivier Cornet Gallery, Dicembre 2020). Con suoi haiku in lingua inglese figura in antologie internazionali, tra le quali The Old Song (Red Moon Press, USA, 2018); Ekphrasis (Gran Bretagna, 2018); Wild Voices (Gran Bretagna, 2018); World Haiku Anthology (Giappone, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); Wishbone Moon (Jacar Press, USA, 2018); Peonies (Bulgaria, 2019), nonché su riviste di settore di vari Paesi, quali Giappone (The Mainichi; Asahi Hakuist Network; NHK Haiku Masters), Austria (Chrysanthemum), Gran Bretagna (Presence; Blithe Spirit; Hedgerow; Ephemerae), Francia (Gong), Stati Uniti (Modern Haiku; The Haiku Foundation; Otata; Akitsu Quarterly; Frameless Sky), Canada (Haiku Canada Review), Russia (Ershik; Utlika), Africa (The Mamba). Alcuni suoi tanka in lingua inglese sono apparsi nei periodici statunitensi Moonbathing e Skylark. In Giappone, è invitata a intervenire alla Conferenza Internazionale della World Haiku Association Haiku Future / Haiku World (Tokyo, 13-15 settembre 2019) nella duplice veste di relatrice sul tema delle criticità della traduzione di haiku contemporanei in lingua latina e di poeta haijin.
Stefano Bertoli è nato in Italia nel 1969, da quasi quarant’anni si divide fra una carriera di Musicista e una di Sound Engineer, Sound Designer. Si appassiona alla fotografia digitale nei primi anni 2000, dopo una lunga esperienza come grafico per le copertine di diverse uscite discografiche. Nel 2020 esce il suo primo libro fotografico: KAWAAKARI (Rivelazioni IÖR) realizzato insieme a dei Cut Off su versi della Poeta Daniela Biasoletto. Il Concept Book successivo, Cielo Cadmio (Kipple Edizioni Librarie) del 2021 è accompagnato, invece, dai versi della Poeta Ksenja Laginja. Kotodama è la sua terza uscita fotografica e seconda parte di una trilogia di Album Fotografici dedicata al Giappone.
LA COLLANA
Collana Fuori è uno spazio per le opere di frontiera di Kipple Officina Libraria, intrise di sensibilità ineffabile da lasciare l’anima e il cuore aperti, istanti di essenza in crescita.
Maria Laura Valente – Stefano Bertoli| Kotodama
– Prefazione di Diego Martina
– Postfazione di Sonia Caporossi
– Traduzioni in lingua anglo-americana di Maria Laura Valente e John Martone
– Traduzioni in lingua giapponese di Ban’ya Natsuishi
Kipple Officina Libraria
Collana Fuori — Formato cartaceo — Pag. 64 – € 15,00 — ISBN 978-88-32179-90-3
Link
- su Kipple Officina Libraria: https://shorturl.at/beAW4
Eventualità
La difficoltà di essere se stessi di fronte al proliferare frattale, mentre le verità collassano e possono non essere nemmeno verità.
Grazie a Matteo Scarfò e Andrea Lupia
![]() Desidero ringraziare pubblicamente Matteo Scarfò per la sua competente presentazione di ieri sera al Teatro Flavio di Roma, dove ha illustrato il mio raccoltone di romanzi Psiconauti dimensionali con domande assolutamente pertinenti e oltremodo intelligenti; mi sono sentito molto a mio agio anche grazie alle splendide letture di Andrea Lupia dei brani che Matteo ha scelto, viaggi indietro nella percezione delle mie cose, nei mood e nelle trascendenze che hanno animato un percorso della mia vita.
Desidero ringraziare pubblicamente Matteo Scarfò per la sua competente presentazione di ieri sera al Teatro Flavio di Roma, dove ha illustrato il mio raccoltone di romanzi Psiconauti dimensionali con domande assolutamente pertinenti e oltremodo intelligenti; mi sono sentito molto a mio agio anche grazie alle splendide letture di Andrea Lupia dei brani che Matteo ha scelto, viaggi indietro nella percezione delle mie cose, nei mood e nelle trascendenze che hanno animato un percorso della mia vita.
Grazie, davvero col cuore.
Extramondi 24 – Rotta verso l’ignoto | Oggi 3 maggio presentazione di “Psiconauti dimensionali”
 Oggi 3 maggio, alle 19.30 presso il Teatro Flavio in Roma, presenterò la raccolta di miei romanzi Psiconauti dimensionali, edita da Kipple Officina Libraria; l’occasione sarà la rassegna Extramondi – Rotta per l’ignoto dei nuovi territori del Cinema fantastico italiano: Matteo Scarfò guiderà il pubblico attraverso i meandri psichici e dimensionali contenuti nei romanzi, mostrando gli elementi sciamanici, quantici, mistici, matematici, imperialconnettivi.
Oggi 3 maggio, alle 19.30 presso il Teatro Flavio in Roma, presenterò la raccolta di miei romanzi Psiconauti dimensionali, edita da Kipple Officina Libraria; l’occasione sarà la rassegna Extramondi – Rotta per l’ignoto dei nuovi territori del Cinema fantastico italiano: Matteo Scarfò guiderà il pubblico attraverso i meandri psichici e dimensionali contenuti nei romanzi, mostrando gli elementi sciamanici, quantici, mistici, matematici, imperialconnettivi.
L’appuntamento è in Via Giovanni Mario Crescimbeni 19, ci vediamo lì?
Teofanie vegetali. Il simbolismo delle piante nell’opera di Ernst Jünger
Tutti gli obiettivi sono effimeri, solo il movimento è eterno e porta con sé, senza sosta, scenari magnifici e spietati. Potersi richiudere nella propria sublime mancanza di scopo come in un’opera d’arte o nel cielo stellato è un lusso che solo pochi si possono permettere. Ma chi in questa guerra vede solo negazione e sofferenza e non l’affermazione, il massimo dinamismo, allora avrà vissuto da schiavo. Costui avrà avuto solo un’esperienza esteriore, non un’esperienza interiore. Ed ecco volare via la vita, la grande emozione, la volontà di combattere e di conquistare il potere nelle forme della nostra epoca, la nostra forma, la forma più ostinata e robusta che si possa immaginare. Dinanzi a tale potente, perpetuo rifluire verso la battaglia, tutte le opere s’annichiliscono, tutti i concetti si svuotano, e si coglie un che di elementare e grandioso che è sempre stato e sempre sarà, anche quando non ci saranno più né uomini né guerre.
Questo uno degli estratti che ho preso da AxisMundi per introdurre un post su Ernst Jünger, di cui m’interessano molteplici aspetti esoterici e simbolici che portano a una visione distaccata dell’esistenza, e dei valori che possono essere celati dalla completa antropizzazione delle cose; un estratto:
Studiando l’opera e la vita di Ernst Jünger non si può che rimanere sopraffatti di fronte a un pensatore che, proprio in virtù delle sue esperienze estreme, è stato in grado di avvicinarsi (usando un termine a lui caro) alla fonte stessa dell’Essere. Ci troviamo di fronte a un uomo che, solo per citare alcuni aspetti della sua biografia, scappò di casa a sedici anni per arruolarsi nella legione straniera, che combatté due guerre mondiali rimanendo ferito oltre quindici volte, che esplorò l’estasi e il terrore degli stati alterati di coscienza attraverso alcol, tabacco, cannabis, hashish, cocaina, etere, cloroformio, mescalina, funghi psilocibinici, LSD – perfino un pericoloso vino di mandragora che cita in un suo carteggio con Albert Hoffmann [1]; il tutto, per poi morire alla veneranda età di 103 anni. Nato, infatti, nel 1895, si spense nel 1998 dopo aver attraversato più di un secolo, dopo aver partecipato ai più importanti drammi storici del ‘900, sopravvivendo a tutti i principali protagonisti di prima e seconda guerra mondiale e avendo perfino il tempo di veder innalzare e cadere il muro di Berlino.
Ma l’aspetto più importante della sua opera – e con opera si intende tanto la sua opera letteraria, quanto la Grande Opera della sua vita – è che egli non si fece trascinare da questo intenso vortice di eventi come un semplice testimone, ma alla stregua di un alchimista riuscì a distillare un senso metafisico da ciascuna esperienza, fosse essa meravigliosa o terribile. Che si leggano i suoi diari di guerra, i suoi saggi filosofici o i suoi romanzi e racconti, si ha la percezione di un pensiero che non nasce soltanto sulla carta, ma che è stato prima scolpito nella carne e nel sangue, nella gioia e nella sofferenza, e dietro a ogni riflessione si riesce a intravedere una profondità che va oltre le lettere e l’inchiostro. Ci sono passi in cui ci si sente accompagnati sul bordo di un precipizio, la cui vista toglie il respiro ma sul cui fondo percepiamo nascondersi un mistero fondamentale dell’esistenza. Un mistero che Jünger è stato in grado di sondare, con la sua esperienza, e che ora ci invita a cogliere – ma al costo di lanciarsi al di sotto con lui.
D’altronde, troviamo, come in Junger, anche nell’esperienza di un altro pensatore-soldato del novecento, Filippo Tommaso Marinetti, la sensazione che giunti alla sbarra che separa la vita dalla morte l’uomo sia messo in contatto con forze eterne, strettamente legate al significato dell’esistenza. Come scrive Marinetti ne L’Alcova d’acciaio narrando l’infuriare di una battaglia:“In uno squarcio di luce ancor torbida una allucinazione o una realtà stranissima assale i miei occhi. Ogni soldato che spara sussultando al suo parapetto ha uno strano alone azzurro-rosso intorno a sé. Sembra un molle globo di nebbia, una ruota di fumo azzurrino. Mi alzo e nell’angosciosa precipitante frenesia della fucileria seguo la trincea. Certo ogni combattente appare ai miei occhi come un nucleo opaco o meglio come il mozzo di quella misteriosa ruota di diafano azzurro. Intuisco così la presenza della vita vissuta che avviluppa ogni combattente nel momento della battaglia. Sono grovigli di giorni passati, di gioie godute, di dolori sofferti che affettuosamente si arrotondano sull’uomo nel giuoco supremo; quando le forze ostili lo assaltano da ogni parte. Ogni ruota azzurra è diversa dall’altra, non so se per l’età, le condizioni di vita, o la coscienza. Malgrado le ondate sbattenti dei fragori e degli echi polifonici io odo quelle ruote azzurre veramente vive chiamare, gridare, implorare. […] Ecco sfioro la schiena d’un forte soldato dal viso cotto dal sole: sono nel suo alone azzurro e tremo come chi entra nella casa dove è morto qualcuno fra pianti disperati. Il soldato che m’è vicino e che spara, spara, affrettando i colpi è forse un marinaio. Chi pensa più alle fischianti pallottole che cinguettano sul capo coi primi passeri indifferenti? Sono preso dalla gioia di scoprire una nuova legge. Ben lontano dai Bergson seduti nelle cretine poltrone universitarie trovo nel momento più pericoloso d’una battaglia la soluzione di molti problemi che i filosofi non potranno mai scoprire nei libri, poiché la vita non si svela che alla vita. Il segreto amplesso del passato e del futuro nella stessa coscienza si rivela a coloro che tutto il passato hanno vissuto, sudato, pianto, baciato, morso e masticato e che vogliono fra le carezze o le gomitate della morte vivere, baciare, masticare e soffrire il loro futuro”.
Extramondi 24 – Rotta verso l’ignoto | 3 maggio presentazione di “Psiconauti dimensionali”
 Il 3 maggio, alle 19.30 presso il Teatro Flavio in Roma, presenterò la raccolta di miei romanzi Psiconauti dimensionali, edita da Kipple Officina Libraria; l’occasione sarà la rassegna Extramondi – Rotta per l’ignoto dei nuovi territori del Cinema fantastico italiano: Matteo Scarfò guiderà il pubblico attraverso i meandri psichici e dimensionali contenuti nei romanzi, mostrando gli elementi sciamanici, quantici, mistici, matematici, imperialconnettivi.
Il 3 maggio, alle 19.30 presso il Teatro Flavio in Roma, presenterò la raccolta di miei romanzi Psiconauti dimensionali, edita da Kipple Officina Libraria; l’occasione sarà la rassegna Extramondi – Rotta per l’ignoto dei nuovi territori del Cinema fantastico italiano: Matteo Scarfò guiderà il pubblico attraverso i meandri psichici e dimensionali contenuti nei romanzi, mostrando gli elementi sciamanici, quantici, mistici, matematici, imperialconnettivi.
L’appuntamento è in Via Giovanni Mario Crescimbeni 19, ci vediamo lì?