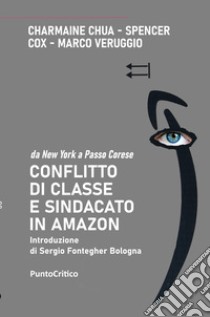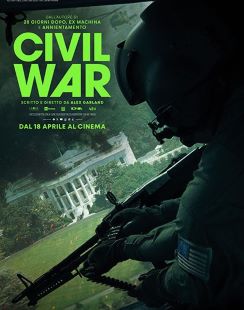HyperHouse
NeXT Hyper ObscureArchivio per Recensioni
Challengers | FantasyMagazine
 Su FantasyMagazine la recensione a Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, regista che qualche anno fa ho tanto apprezzato nel suo rifacimento – ma direi più riscrittura – di Suspiria. Vi lascio alle note critiche:
Su FantasyMagazine la recensione a Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, regista che qualche anno fa ho tanto apprezzato nel suo rifacimento – ma direi più riscrittura – di Suspiria. Vi lascio alle note critiche:
Art è un giocatore di tennis ormai a fine carriera. Sua moglie Tashi che gli fa da manager e da coach, per farlo tornare in carreggiata e riacquistare la fiducia in vista degli US Open, decide d’iscriverlo a un challenger, ovvero un incontro di livello inferiore nel mondo dei tornei professionistici. Arrivato in finale Art trova però dall’altra parte del campo Patrick, un giocatore finito in disgrazia e decisamente meno blasonato di lui e che pure gli dà parecchio filo da torcere. Si scopre che i due anni prima erano migliori amici e condividevano la passione per il tennis da quando avevano dodici anni, vincendo anche un torneo di doppio insieme. A sconvolgere la loro amicizia era stata Tashi, una tennista promettente che da prima aveva iniziato una relazione con Patrick ma, dopo un’incidente che l’aveva costretta al ritiro, aveva preferito Art. La donna aveva riversato sul marito le speranze per la sua carriera sfumata, ma ora che lui pensa al ritiro e dopo la ricomparsa di Patrick ogni equilibrio nella vita dei tre rischia di saltare.
Challengers mostra una partita a tre giocata con pari volontà anche se con ruoli diversi dai protagonisti, contravvenendo alla regola del tennis in cui la partita si gioca in due o al massimo in quattro. Ogni punto perso e dato all’avversario è sempre dovuto a una scelta che si propaga come un’onda nel presente e che determina ciò che è stata la vita di Art, Patrick e Tashi. Guadagnino è bravissimo a raccontare questo match come se fosse davvero una partita usando diversi piani temporali: il presente in cui i due ex amici si affrontano e il passato dove pian piano si ricostruisce la loro complessa personalità e ciò che li lega a Tashi. Ma è lei il personaggio più interessante del film poiché non viene di certo ritratta come una damigella contesa, ma neppure come una strega interessata solo alla celebrità. “Non sono una rovina famiglie” dice quando conosce i due, e in effetti la relazione tra di loro è influenzata più che dal sesso dalla sua necessità di controllo.
Il Re in Giallo | HorrorMagazine
 Su HorrorMagazine la recensione di Cesare Buttaboni a “Il Re in Giallo”, di Robert W. Chambers, edito dai tipi dell’Ippocampo. Di cosa si tratta?
Su HorrorMagazine la recensione di Cesare Buttaboni a “Il Re in Giallo”, di Robert W. Chambers, edito dai tipi dell’Ippocampo. Di cosa si tratta?
Nell’oscura vastità della letteratura fantastica, pochi volumi conservano la stessa aura enigmatica e il potere evocativo di Il Re in Giallo di Robert W. Chambers. In questa nuova incarnazione curata da L’Ippocampo, l’opera risplende di una fresca luminosità.
Sin dalla sua enigmatica presentazione, il lettore viene trascinato in un labirinto di angoscia e suggestione. I racconti racchiusi in questa collezione si ergono come monoliti dell’immaginazione distorta di Chambers, ciascuno offrendo una panoramica unica sull’abisso della psiche umana. I primi quattro racconti, noti come il nucleo del ciclo, tessono un tappeto di terrore cosmico e ambizione umana, dipinto con le sfumature precise di uno spirito tormentato.
Ma la bellezza di Il Re in Giallo risiede anche nella sua capacità di catturare l’estetica decadente e romantica dell’epoca. Racconti impregnati di miti brettoni trasportano il lettore in un mondo di simboli e maschere, rivelando l’approccio unico di Chambers al fantastico, intriso di simbolismo e decadentismo.
L’edizione di L’Ippocampo non solo celebra il genio letterario di Chambers, ma getta anche nuova luce sulla sua influenza duratura nella letteratura fantastica. Attraverso la prefazione, l’appendice include il racconto di Ambrose Bierce Un cittadino di Carcosa e la postfazione di S.T. Joshi, il lettore è guidato in un viaggio affascinante attraverso il cuore oscuro di Il Re in Giallo. In conclusione, Il Re in Giallo di Robert W. Chambers, nella sua nuova incarnazione fornita da L’Ippocampo, si erge come un pilastro della letteratura fantastica. Con la sua prosa tagliente e la sua capacità di evocare visioni di un’oscurità primordiale, Chambers continua a esercitare il suo fascino sui lettori di oggi. Questa nuova edizione non solo soddisferà i fan fedeli, ma anche coloro che sono pronti a esplorare i confini del terrore e della bellezza, dove l’ombra e la luce si mescolano in un balletto eterno.
Il grande dio Pan | HorrorMagazine
 Su HorrorMagazine la recensione di Cesare Buttaboni a “Il grande dio Pan”, di Arthur Machen, un classico edito nuovamente con alcune aggiunte; per cui, ecco Cesare che c’illustra le novità di quest’edizione:
Su HorrorMagazine la recensione di Cesare Buttaboni a “Il grande dio Pan”, di Arthur Machen, un classico edito nuovamente con alcune aggiunte; per cui, ecco Cesare che c’illustra le novità di quest’edizione:
Ma non è solo il romanzo a catturare l’attenzione del lettore. In questa nuova edizione, Ippocampo Edizioni ha incluso anche una serie di racconti che arricchiscono ulteriormente l’universo narrativo di Machen. La luce interiore, La storia del sigillo nero, Storia della polvere bianca e La piramide di fuoco (pur se si tratta di storie note e più volte antologizzate) s’inseriscono perfettamente nel contesto della Londra macabra e misteriosa creata dall’autore, aggiungendo nuovi elementi di terrore e fascino alla narrazione. Le prefazione di Guillermo del Toro aggiunge un ulteriore strato di profondità a questa opera, sottolineando la sua importanza nel panorama della letteratura dell’orrore.
Troviamo poi una preziosa introduzione dello stesso Arthur Machen intitolata in francese ovvero Par-delà le pont des années in occasione della riedizione del romanzo nel 1916 presso l’editore Simpkin. La postfazione di S.T. Joshi ci offre un’analisi approfondita delle influenze di Machen su autori successivi, come H.P. Lovecraft, evidenziando l’impatto duraturo di questo romanzo e dei suoi racconti nel mondo della narrativa fantastica. Infine, le illustrazioni di Samuel Araya completano l’opera, offrendo un accompagnamento visivo che amplifica il senso di inquietudine e meraviglia che permea ogni pagina. Il Grande Dio Pan in questa nuova edizione si rivela non solo un romanzo da leggere, ma un’esperienza da vivere, un viaggio nelle profondità più oscure della psiche umana, dove il terrore e il fascino si fondono in un turbine di emozioni contrastanti. Preparatevi a essere trasportati in un mondo dove il divino e il demoniaco si mescolano, dove ogni angolo nasconde un segreto, dove l’ombra del grande dio Pan attende di essere rivelata.
La gora del sacrificio e altre storie weird di Algernon Blackwood – Planet GHoST
 Sul Club G.Ho.S.T. una recensione di Cesare Buttaboni a “La gora del sacrificio e altre storie weird di Algernon Blackwood”, a cura di Claudio Foti. Il tomo contiene una sequenza di racconti editi ma anche inediti del maestro inglese, così vi lascio alla rece di Cesare, che illustra molto bene le tematiche di Blackwood:
Sul Club G.Ho.S.T. una recensione di Cesare Buttaboni a “La gora del sacrificio e altre storie weird di Algernon Blackwood”, a cura di Claudio Foti. Il tomo contiene una sequenza di racconti editi ma anche inediti del maestro inglese, così vi lascio alla rece di Cesare, che illustra molto bene le tematiche di Blackwood:
È un’immersione nel mistero, nella magia e nell’occulto che Blackwood ha saputo tradurre così abilmente nei suoi scritti. La raccolta abbraccia un ventaglio di racconti, alcuni dei quali erano ormai dimenticati e introvabili da decenni. Foti ci guida attraverso questo viaggio nel tempo letterario, mettendo in luce il valore storico e culturale di ogni singolo racconto. Resti Romani, La Follia di Jones, La Casa Vuota e gli altri, risplendono ancora una volta sotto la luce della sua cura editoriale, rivelando aspetti oscuri e inquietanti dell’immaginario di Blackwood. Ma è nei racconti inediti che questa raccolta raggiunge la sua massima potenza. Immaginazione, La Gora del Sacrificio, Stregonerie Egizie e Il Sacrificio si ergono come pietre miliari dell’opera di Blackwood, portando il lettore in territori ancora più remoti e misteriosi. In questi racconti l’autore si libra tra le nebbie dell’ignoto sondando le profondità dell’anima umana e dell’universo stesso. Ci troviamo di fronte a storie che non solo ci coinvolgono emotivamente, ma ci spingono a riflettere sulle più oscure e inspiegabili sfaccettature della realtà. Attraverso la prosa di Blackwood ci addentriamo in mondi in cui il confine tra il reale e il soprannaturale si dissolve, lasciandoci senza parole di fronte alla sua maestria nel dipingere atmosfere inquietanti e visionarie. In conclusione La gora del sacrificio e altre storie weird di Algernon Blackwood è molto più di una semplice raccolta di racconti. È un viaggio nella mente di uno dei maestri indiscussi del genere weird, un’esplorazione delle profondità dell’umano e dell’ignoto che ci circonda. Grazie a Claudio Foti, possiamo finalmente immergerci completamente in questo mondo oscuro e affascinante, lasciandoci rapire dalle sue infinite possibilità e dalla sua straordinaria capacità di incantare e spaventare allo stesso tempo.
Recensione a “I Salmi dell’Apocalisse” di Miriam Palombi | di Walter Bianco
[Letto su KippleBlog]
 Nuova recensione a I salmi dell’Apocalisse, romanzo di Miriam Palombi edito nella collana k_noir di Kipple Officina Libraria, curata da Paolo Di Orazio; autore della recensione è Walter Bianco, che dalle pagine del suo blog scrive ciò:
Nuova recensione a I salmi dell’Apocalisse, romanzo di Miriam Palombi edito nella collana k_noir di Kipple Officina Libraria, curata da Paolo Di Orazio; autore della recensione è Walter Bianco, che dalle pagine del suo blog scrive ciò:
“I Salmi dellApocalisse” è un romanzo profondo e impegnativo che vincola in maniera totale il lettore che, assorbito da una curiosità quasi morbosa, viene spinto verso il limite per confrontarsi con una paura intima ed enigmatica che si manifesta in questo viaggio nella dimensione oscura che parte e ritorna dalla profondità dell’animo umano. Il libro esprime tutto l’interesse e la passione della Palombi riguardo la simbologia e in particolare per tutti gli elementi esoterici che, in in questo suo ultimo, assumono sfumature dai forti connotati Kafkiani.
Tantissimi complimenti alla bravissima Miriam Palombi che ancora una volta conquista attraverso una capacità stilistica che trasmette voglia di conoscenza su mondi oscuri e incomprensibili, che affascinano ancora di più perché rivelati in luoghi che abitualmente dovrebbero garantire tranquillità e sicurezza; le sue storie sono sempre capaci di disarmare certezze andando ad intaccare una fragilità umana che molto spesso, davanti a qualcosa che la ragione non può spiegare, viene scossa fin dalle viscere.
LA QUARTA Villa Daleth svetta tra le altre dimore borghesi di un distinto quadrante di Roma. È stata progettata nella sua forma ottocentesca dall’architetto Coppedè, famoso per aver dato il nome all’omonimo quartiere liberty. Ma il palazzo ha il suo senso, diverso da quello che si aspetterebbero i suoi garbati ospiti, e vive di un paradigma proprio. E poi la numerazione degli appartamenti in cui è suddiviso l’edificio ha una sua logica inspiegabile. E perché le connessioni di questo palazzetto affondano anche in altri luoghi dell’Italia, rincorrendo i fili tenaci e sottili della Storia? E cosa c’entra, infine, la psichiatria di Wilhelm Reich?
Scopri di più sul sito della Kipple Officina Libraria.
La Divina – Isabella Santacroce – recensione
 Cesare Buttaboni recensisce La Divina, di Isabella Santacroce, nome che riemerge dagli abissi dell’oblio; però, sembra valerne la pena:
Cesare Buttaboni recensisce La Divina, di Isabella Santacroce, nome che riemerge dagli abissi dell’oblio; però, sembra valerne la pena:
“Quando un uomo si innamora di me vorrei tagliargli la gola, vederlo crepare davanti ai miei occhi, dargli fuoco. Il potere di una donna è nel disprezzo”.
Pubblicato per scelta al di là dell’editoria convenzionale, “La Divina” vede la luce grazie alla Desdemona Undicesima Edizioni (la mia è la copia numero 415), conferendo al romanzo un’aura di indipendenza e originalità che si riflette nella sua trama audace e nelle sue tematiche complesse.Il libro è dedicato a re Ludwig II di Baviera, il monarca considerato pazzo e deposto, che un giorno disse: «Voglio rimanere un eterno enigma, per me e per gli altri». Il riferimento al re Ludwig II di Baviera, il “re dei cigni”, e al suo desiderio di rimanere un enigma irrisolvibile, riflette il tema dell’incognita e del mistero che pervade anche il romanzo. Questa sensazione di essere un enigma universale, un sentimento con cui molti possono identificarsi, si intreccia con la ricerca personale di serenità, una dimensione che sembra sfuggire. La protagonista è Eva, “incantevole e folle, angelo pieno di demoni, regina della perdizione e della purezza, libera di sognare la felicità nell’impossibile”.
Nell’oscurità profonda di “La Divina” di Isabella Santacroce, ci si immerge come in un abisso avvolgente, un mondo intriso di colpa e desiderio, in cui l’eros e il thanatos danzano una danza macabra sotto lo sguardo implacabile della Divina Padrona. Attraverso uno stile colto e decadente, Santacroce ci conduce in un regno sospeso tra il terreno e il divino, in cui la figura della Divina domina sovrana, incarnando un’entità mitica che trascende la carne e l’anima. Sotto il suo regno, il BDSM diviene un rituale sacro, una via per l’estasi religiosa, in cui il dolore e la sottomissione sono vie per il riscatto e la redenzione. In questo labirinto di piaceri e tormenti, la Divina si erge come una Grande Madre, una Dea implacabile che trae potere dal disprezzo e dalla distruzione. Attraverso la sua figura, Santacroce esplora i confini estremi dell’esistenza umana, spingendo il lettore oltre i limiti della sua stessa natura. Tuttavia, dietro la maschera della dominazione e del piacere, si cela una discesa agli abissi dell’anima umana, un viaggio verso l’oscuro nucleo dell’esistenza. Come afferma la protagonista, “la vita è una cosa strana se ci pensi, anche quando splende è ignobile”, eppure è proprio in questa oscurità che si trova il nucleo intoccabile, il mistero insondabile che ci spinge ad andare avanti. Attraverso una prosa incisiva e visionaria, Santacroce ci svela i misteri dell’amore e della morte, mostrandoci la bellezza e la brutalità della condizione umana. “La Divina” non è solo un romanzo sul BDSM, ma un’opera che sfida le convenzioni e le certezze, spingendo il lettore verso l’ignoto, verso le profondità insondabili della propria anima.
La porta dell’irreale | HorrorMagazine
 Su HorrorMagazine una recensione di Cesare Buttaboni a “La porta dell’irreale”, di Gerald Biss, uscito per la collana “La biblioteca di Lovecraft” di Arcoiris; un estratto:
Su HorrorMagazine una recensione di Cesare Buttaboni a “La porta dell’irreale”, di Gerald Biss, uscito per la collana “La biblioteca di Lovecraft” di Arcoiris; un estratto:
Nelle fitte pieghe del tempo e dello spazio, si cela un mondo oscuro e misterioso, dove le leggi della realtà vacillano e la magia dell’ignoto danza con l’immaginazione dell’uomo. In La porta dell’irreale, il capolavoro soprannaturale di Gerald Biss finalmente viene pubblicato in Italia grazie alle edizioni Arcoris nella collana “La biblioteca di Lovecraft” curata da Jacopo Corazza e Gianluca Venditti. Quest’opera, lodata persino dall’oscuro maestro Lovecraft, getta uno sguardo audace in un regno dominato da licantropi, nobili decaduti e misteri avvolti nel sottile velo della notte.
La porta dell’irreale non è solo un romanzo di licantropi e misteri gotici; è un’opera che sfida i confini della realtà e invita il lettore a esplorare le profondità dell’animo umano. Con la sua scrittura magnifica e la sua capacità di incantare e sorprendere, questo libro merita di essere annoverato tra i grandi classici del genere gotico. Gerald Biss si distingue come un maestro dell’oscuro e del sovrumano, e la sua opera non mancherà di lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chiunque si avventuri attraverso la sua “porta dell’irreale”.